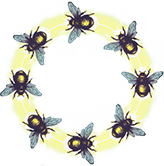Il bravo cantastorie – intervista a Vinicio Capossela
«Non si muore tutte le mattine» è il primo libro di Vinicio Capossela, cantastorie e affabulatore di parole e musica. Non è il solito romanzo, la trama è un intreccio di vicende che a volte si incrociano tra loro, a volte si concludono nel giro di poche pagine. Tutto ruota attorno all’impresa del vivere, dove ognuno ha la sua personalissima epica. Per trovarla basta seguire le istruzioni per l’uso suggerite dall’autore: «Prendere le pagine a etti, sfuse, a capitoli», seguire, ognuno come vuole, una trama che non c’è e immergersi nella quantità. A catturarvi saranno i protagonisti: i sollevatori di peso e i viaggiatori, i carcerati e i rebetici [il rebetico è una musica greca, viene dalla parola «rebet», ribelle], i migranti e gli animali del Chiavicone, Glenn Gould e Tony Castellano, gli alpini e Napoleone. In un via vai di luoghi e immagini reali o inventati: tangenziali, motel, la piana ipermercata, la balera di Maldonado, l’autobus per Sarajevo e gli scantinati. Abbiamo raggiunto Capossela tra un reading e l’altro, presentazioni nelle quali la musica accompagna un testo che si presta alle letture «partecipate».
Quando è cominciata questa nuova avventura?
Sull’orlo della gioventù, dopo aver deragliato per due o tre anni, nei quali davo come indirizzo la targa della mia automobile…alla fine, dopo tanto rotolare, mi sono ritrovato su un piano rialzato, in via Lamarmora, tra una caserma e tre cliniche geriatriche. Ho sentito il bisogno di vuotare il sacco, c’erano diverse questioni su cui valeva la pena parlare. Ho iniziato scrivendo a macchina, poi ho comprato un computer di seconda mano come faccio con tutto, ma un virus mi ha distrutto quello che avevo scritto. Il mio approccio all’informatica è passato attraverso la malattia…
Mi sono rinchiuso, come assediato da qualche cosa, subito dopo Il ballo di San Vito [album uscito nel 1996 ndr]. Cercavo qualcosa di epico, volevo mettere assieme personaggi vicini e lontani. Tra questi, c’è un mio carissimo amico che compare con il nome di Nutless, in omaggio al capolavoro di Sergio Leone, C’era una volta l’America. Lui, per esempio, a un certo punto voleva diventare campione del mondo, non so come si dica, nella specialità di dipingere i soldatini di piombo. Voleva avvicinarsi alla Storia attraverso la cosa apparentemente più piccola… e tra i miei autori preferiti c’è Conrad, un suo librino dal titolo «I duellanti». Insomma, arriva il momento che vuoi fare l’impresa. È come un fuoco d’artificio che scoppia e lo racconti insieme al limite che porta con sé. Ci sono state diverse pause, è stata una lunga gestazione interrotta da concerti e viaggi. Così si sono stratificati luoghi, personaggi, persone…
Per questo hai deciso di scrivere un libro, si è scatenato il bisogno della scrittura?
Dalla «strozzatura», da quella è nato tutto. La vita ci darebbe infinite possibilità, come la catapulta. Allora, succede che anche sei hai il carburante la macchina si ingolfa, si ottura perché è troppo. È la fine della gioventù, la colica dell’immaginazione che si placa solo nel rinchiudimento. Almeno questa è stata la mia esperienza. Per arrivare a capire come da rondini si diventa mosconi, o, come ho cercato di raccontare nel capitolo sulla sorte di Kerouac, cosa gli è successo?
È una narrazione ricca, piena di voci…
Sì, è una polifonia in senso bachiano/pacchiano a quattro voci. La prima persona è quella che più mi è vicina, le altre sono contigue alla mia esperienza. Ho scritto racconti fatti per la voce. Mi piacerebbe sentirli leggere da altri, con altri accenti, in altre lingue. La scrittura dovrebbe sopperire la voce. Ecco, vorrei sentirmi il corpo di questa voce. Sono molto affezionato alle letture, leggere ad alta voce, a metà tra il circo e il teatro, la cosa più vecchia del mondo: raccontare storie. È qualcosa di reciprocamente sincero ed emozionante, per te che leggi e per chi ascolta. Del resto, Majakovskij bisogna leggerlo ad alta voce. Kerouac, anche se non capisco bene l’inglese, è un piacere sentirlo.
Nel libro ci sono mancate partenze e viaggi in luoghi che evocano conflitti e guerre dimenticate.
Tra le prime ci sono le tangenziali o La Bruciata, come chiamano il casello tra la A1 e la A22, o ancora certi angoli della città. Anche questo è qualcosa di grande e di epico, vicinissimo a noi. Invece, il viaggio nella ex Jugoslavia, come si dice ora, è stato diverso. Per chi come me è cresciuto in Emilia Romagna, era il primo viaggio. Per noi cresciuti ai margini del socialismo, nella casa del partito, partire per quei luoghi era come andare a trovare l’infanzia di vent’anni prima. Sulla guerra…direi che l’orrore più vicino sembra già vecchio. Ma a volte i particolari dicono di più. Mi è capitato una volta che sono arrivato sul luogo di un incidente stradale, io non ho visto quello che era accaduto, ma solo una scarpa a venti metri. Diceva tutto. Così le macerie, senza entrare nel cuore della storia, possono dire di più. Del resto, a me capita di incontrare i residui delle cose più che le cose. Lo stesso vale per le registrazioni che sentiamo: ascoltiamo Charlie Parker, ma chi lo ha mai conosciuto? Credo sia importante raccontare le cose nei loro residui «materici», descrivere di un paesaggio quello che ne è rimasto.
Tra i personaggi storici del libro, incontriamo spesso Napoleone. Come mai ci sei così affezionato?
Nel periodo in cui ho cominciato a scrivere stavo leggendo l’epopea napoleonica. Quello che mi attira di più è la vasca da bagno all’Isola dell’Elba, la consumazione dell’impresa. Sopravvivere e morire. Il tempo divora le cose grandi e le più semplici. Come l’amore, che è la più grande delle imprese.
Chi conosce le tue canzoni, ritrova nel libro anche vecchie conoscenze come la Contrada Chiavicone. Cos’è questa Contrada?
È il luogo dell’esotismo a portata di mano, dove nessun contorno è perfetto, c’è Dum Dum, il viaggiatore, poi ci sono i pappagalli, le voci impigliate… È il posto fuori dalla strada, quello a cui arrivi uscendo dall’autostrada, il posto della nonna, dove ti puoi arrampicare sugli alberi o seppellire la macchina. È un luogo lussureggiante, delle fiabe, delle streghe, delle ciarlatane…
Scrivi: «L’unico modo per renderla tollerabile, la vita, era sfuggirla. Sovvertirla».
Siamo abituati al fatto che tutto ha un certo modo di essere conosciuto-riconosciuto: quello che nel libro assume le sembianze del doppiovetro, dell’umanità rassicurata. Invece, se guardi da un’altra visuale, la cosa che hai sempre avuto dinanzi agli occhi è come un regalo, brilla di una sua epica. Forse faccio del romanticismo, non so. È più intrigante se qualcuno ti fa vedere una cosa a portata di mano sotto un’altra luce. Questo è sovvertire.
Nel tuo libro molti personaggi si ritrovano in una sorta di girone dantesco, perché?
L’idea del girone è quella di una collettività di una sola specie. Come quella che descrivo nella «piana ipermercata», luogo immaginario che rappresenta la quantità che ci seppellisce, ci invade, dove non ci si ritrova, non ci si rispecchia più, dove tutto abbonda e devi pagare per entrare.
[Vinicio Capossela, “Non si muore tutte le mattine”, Feltrinelli, pag. 336, 8 euro]
(pubblicato su Carta 20/2004, www.carta.org)