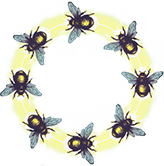La doppia vita della storica – Intervista a Emma Baeri
La prima cosa che colpisce, prendendo in mano il volume Dividua. Femminismo e cittadinanza è un dettaglio: il doppio cognome, Baeri Parisi. Indipendentemente dalla mancata legge in Italia sul cognome materno, Emma Baeri Parisi già da tempo li usa entrambi: è la volontà di una femminista che desidera ricordare i cognomi delle sue bisnonne, delle nonne, della madre e delle figlie, come recita la dedica. Ad accompagnarla in questa scelta anche due giovani donne, Elena Caruso Raciti e Antonia Cosentino Leone che hanno letto – e commentato – per prime il testo. Il libro, infatti, raccoglie interventi, saggi e riflessioni che Baeri ha svolto negli ultimi decenni su diversi temi, uno su tutti la piena cittadinanza delle donne, che sia finalmente compiuta. Il suo intento nasce dalla pratica femminista, vissuta a più riprese, e dalle sue ricerche come in-segnante universitaria [Emma quando parla fa una pausa e fa il gesto del mettere un segno, da qui in-segnante, nel parlato e nello scritto], sperimentando anche nella didattica un nuovo modo di stare al mondo per donne e uomini, a partire da un nuovo modo per nominarsi e rappresentarsi. È anche la testimonianza – preziosa – di un dialogo fra donne di generazioni differenti e il desiderio tenace di produrre memoria, di lasciare impronte visibili, soprattutto condivisibili.
Da dove è nata l’idea o quando hai sentito il bisogno di inventare la parola dividua/e?
«La parola “dividua” si è formata nella mia mente alcuni anni dopo aver concepito l’idea – la necessità! – di un Preambolo alla Costituzione (1997), un breve testo che, nel rispetto dei fondamenti della Carta, vuole essere una guida di lettura e di interpretazione della Costituzione; una guida fondata sulla nuova semantica della “differenza sessuale” come valore reciproco, e sul nesso emancipazione-liberazione che la pratica femminista ha affermato attraverso vent’anni di autocoscienza e di lotte per i diritti: le leggi per l’aborto e contro la violenza sessuale sono state cerniere di cittadinanza. Ma l’idea di dividualità ha un fondamento nella mia esperienza: tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi degli anni Settanta sono diventata due volte madre, eventi accaduti entrambi, apparentemente, nell’ordine naturale delle cose, che avevano invece mutato “visceralmente” il senso della mia vita, i miei desideri, i miei bisogni. Vent’anni dopo questi eventi “naturali” Lea Melandri mi ha invitata a rifletterci su e a scriverne per la rubrica “Racconti di nascita” (Nascite e rinascite, “Lapis” 9, 1990). Da quel momento in poi la mia mente non si è più fermata, interrogando e interrogandomi di continuo».
A proposito del nesso emancipazione-liberazione, spesso le donne si fermano alla prima, soprattutto nelle giovani generazioni: dove ha sbagliato il femminismo storico? Dove si è inceppata la trasmissione dei saperi/pratiche che tenevano insieme le due cose?
«Il femminismo storico, quello che attraverso l’autocoscienza e il self help ha per la prima volta chiamato sulla scena pubblica e politica la sessualità e il corpo delle donne – e ha successivamente stabilito un nesso tra queste nuove evidenze e la tradizione dei diritti, dell’uguaglianza e dell’emancipazione – non riesce a varcare la soglia degli anni Ottanta per varie ragioni, interne ed esterne alla sua storia. Per la difficoltà di rendere visibile e trasmissibile un discorso fondato su un’inedita “democrazia” dei piccoli gruppi, per la perdita di un quadro di riferimento forte nelle vicende della Nuova Sinistra e della Sinistra Storica, per l’emergere di nuovi modelli femminili, sostenuti da un accelerato decadimento dei mezzi di comunicazione di massa. Nasce in quegli anni una sorta di neoemancipazionismo rampante, paradossalmente, e certo involontariamente, sostenuto da un filone del femminismo italiano, il “Pensiero della differenza”, che ritiene ormai superate le pratiche femministe della sessualità. Questo avviene proprio mentre il discorso patriarcale sulla sessualità femminile (attacco all’autodeterminazione, questioni “etiche” relative alla procreazione assistita) occupa sempre di più lo spazio pubblico-politico. Quel pensiero costruisce un paradigma politico attorno alla figura della Madre simbolica, modello e perno di relazioni tra donne fondate sul riconoscimento della disparità e sull’affidamento, per l’affermazione della libertà femminile nei “commerci sociali”, la conquista dell’agio attraverso la voglia di vincere: queste le parole chiave, “emancipate” sui generis, del “Sottosopra verde” del 1983, da cui origina il nuovo pensiero. Un pensiero forte, rassicurante, ben presto egemonico nel dibattito politico anche grazie all’esplicito sostegno della stampa democratica; un pensiero che attraverso un’opzione dichiaratamente filosofica – che pure libera molte risorse relazionali – rende incorporeo quel ‘sé’ dal quale dice di voler sempre partire; un pensiero esplicitamente storiofobico, che afferma l’irrilevanza dei contesti materiali, del nesso tra donne e democrazia e tra donne e diritti per l’affermazione della libertà femminile. Questo è il nucleo della sua originaria formulazione, nel tempo resa più prudente dall’evidente neocolonizzazione della sessualità femminile, imprigionata tra riadddomesticamento dei ruoli, “diritti” negati e pornocrazia. Penso inoltre che questa egemonia abbia creato un difetto di trasmissione del femminismo alle giovani donne, che avrebbero più facilmente accolto messaggi materialisticamente fondati sulla vita di ciascuna, strumenti utili a orientarsi tra l’inquieta ignoranza della propria sessualità e le questioni legate al lavoro, ai lavori, a cogliere il nesso tra desideri e bisogni o, come dicevamo negli anni Settanta, tra liberazione ed emancipazione».
Come storica delle donne ti sei impegnata molto anche nella didattica, cosa credi ancora manchi affinché il femminismo entri a pieno titolo con la sua storia e la sua teoria nei testi scolastici?
«Occorrerebbe ritessere il nesso tra soggettività della storica, storia delle donne e storia di genere. Agli inizi degli anni Ottanta, proprio mentre in altri luoghi del femminismo maturava il Pensiero della differenza, un consistente gruppo di storiche, in diversi modi legate al femminismo, avvia una riflessione storiografica inedita, che per me ha significato un vero corpo a corpo tra il mio corpo di donna e il corpus disciplinare della storia (I Lumi e il cerchio, Editori Riuniti 1992, Rubbettino 2008). Da questo fermento creativo sarebbe nata nel 1989 la Società Italiana delle Storiche, dove la questione di quel nesso viene posta al centro della riflessione, anche se ben presto semplificata in una partita a due tra storia delle donne e storia di genere, tra storia dell’oggetto e storia del modello. Quello che rimase definitivamente in ombra fu il soggetto storiografico, la storica, che dal femminismo era nata come soggetto politico ed epistemologico: forse troppa fatica, forse paura, forse qualcosa di mutato nel femminismo, l’esaurirsi della riflessione sulla sessualità, una circostanza favorevole a questo oscuramento del soggetto imprevisto. Oggi qualcosa è cambiato, alcuni libri di storia si fregiano di frammenti di storia delle donne, si avvalgono della decostruzione dei generi, ma in nessuno, mi pare, la soggettività della storica “rovescia il tavolo”, e rilegge il passato ponendo tutte le domande necessarie a modificare il senso comune della storia; anche se alcune di loro hanno molto arricchito il dibattito storiografico ponendo questioni certamente stimolanti, poco è cambiato nella scrittura della storia, nella gerarchia delle rilevanze di una storia che ancora si pretende “generale”, ed è piuttosto generica, ancora fondata sul punto di vista e sulle rilevanze di un genere solo, nella insufficiente sperimentazione di una didattica che volevamo creativa, intersoggettiva, dalla scuola dell’infanzia fino alle aule universitarie: a dispetto del senso comune storiografico, questa storia è a tutt’oggi scientificamente discutibile… ma ormai io sono in pensione».
Sei d’accordo con chi dice, soprattutto nella tua generazione, che il patriarcato è in qualche modo finito e siamo nell’era del postpatriarcato?
«Penso che il patriarcato abbia perso in molti luoghi e modi la sua centralità simbolica ma che in molti luoghi e modi materialmente governi ancora. Per questo sono così affezionata al nesso emancipazione-liberazione: nelle more di una compiuta iscrizione delle donne nel patto costituente, le dividue pretendono orgogliosamente tutela purché questa sia data nell’interesse di tutti; come scrisse Olympe de Gouges nel 1791, solo così la tutela viene liberata dalla sua connotazione tradizionale, quella di essere strumento di compensazione dell’inferiorità civile e della minorità sociale delle donne. Solo l’affermazione dell’interesse generale alla tutela delle donne consente nella fase attuale di un patto di cittadinanza deforme una sufficiente costituzionalizzazione della dividualità, che resta altrimenti nell’ordine “naturale”, fuori dalla polis, dove ancora oggi noi donne stiamo come individui, come uomini, non come donne, in-dividue dividuali: a dispetto dell’apparente biologismo, la dividua è una cittadina intera e basta».
I nuovi femminismi chiedono il reddito per l’autodeterminazione e di mettere in discussione il valore del lavoro, così come è stato pensato fin qui anche dalla sinistra. Le femministe degli anni duemila, nonostante o forse per via della precarietà, in sintesi dicono: lavorare per vivere, non vivere per lavorare. Che ne pensi?
«“Lavorare per vivere-non vivere per lavorare” è il chiasmo di una nuova rappresentazione del lavoro. Oltre la sua divisione sessuale? Anche qui, diverse pratiche e culture del femminismo si manifestano. Quanto a me, nel concepire il terzo punto del Preambolo alla Costituzione, il reciproco scambio tra donne e uomini di “lavoro di cura-cura del lavoro”, sentivo che la distinzione tra dentro e fuori segnava (e segna) ancora fortemente la vita quotidiana delle donne e degli uomini, con un evidente aggravio di lavoro materiale e simbolico, di fatica e di frustrazione, per lei, per noi, per me. Non esiste più questo problema? Forse il lavoro di cura comincia ad essere condiviso, ma la cura del lavoro fuori casa vede ancora salti mortali, e disparità di trattamento delle donne. Dico “lavoro”, e subito penso: quale, come. Aggettivi come “precario”, espressioni come “che non c’è” si affiancano a questa parola antica, modificandone il significato storico. Eppure non riesco a prescinderne: “lavorare per vivere” apre infatti un’altra domanda: “vivere come?”, una domanda che richiama il valore socializzante, relazionale, civile, del lavoro. Non credo che questa sia un’eredità esclusivamente marxista. Esperienze di lavoro solidale, di mutuo appoggio, di condivisione e di progettazione di nuove “utopie” non appartengono solo a culture e tradizioni “precapitaliste”, molto spesso segnate da una potente soggettività femminile; anche nel “primo e secondo” mondo esse si manifestano sempre più spesso, e tutte, mi sembra, definiscono un orizzonte del vivere in cui il lavoro è bene comune e collante civile necessario. E sono le donne, soprattutto, le generatrici e le levatrici di questi modi e mondi nuovi».
Perché è così difficile far mantenere nel tempo i gruppi/reti di donne che fanno politica militante?
«Credo che abbiamo molto lavorato sulla differenza dagli uomini, sulle diversità tra noi, sulla disparità nelle relazioni duali ma non siamo mai riuscite a trovare una formula per governare le dinamiche di gruppo sul “fare”, fare dentro/fare fuori: il confine tra il gruppo e la società è difficile, scivoloso, impervio. Le radici di questa impervietà nascono a mio avviso già alla fine degli anni Settanta, quando il “movimento lesbofemminista delle donne” scelse – obtorto collo per alcune, come conseguenza ovvia delle battaglie di emancipazione per altre – di misurarsi con le istituzioni sulla questione “aborto”. Le diversità delle storie di ciascuna, di ciascun gruppo, furono temporaneamente composte nell’emergenza, ma ressero male alla “normalità” della vita politica, anche in ciascun gruppo. Così, ancora oggi, rispetto al “fare fuori”, si ripropone ogni volta il dilemma: o votare a maggioranza o votare all’unanimità. Sciogliere questo dilemma sarebbe liberatorio, e non sempre le tradizionali pratiche politiche di relazione ne sono capaci: ascolto di tutte o prevalere di alcune, di una? Recentemente, in un momento di tensione nato nel mio gruppo “Le Voltapagina” di Catania rispetto a un fare/non fare non da tutte condiviso, ho proposto di sperimentare una pratica che ho chiamato di “libertà solidale”: tutte le volte in cui nasce un dissenso su un evento di visibilità del gruppo, l’evento sarà firmato “alcune di Voltapagina”. Fermo restando il discrimine su eventi palesemente contrari alla storia e all’etica politica che fondano il gruppo, questa scelta, apparentemente banale, dice alcune cose a mio avviso importanti: “alcune di Voltapagina” significa infatti tenere insieme il desiderio di alcune con la solidarietà di tutto il gruppo, significa che il gruppo sostiene quel desiderio anche se non è condiviso da tutte. Insomma, mi è sembrato questo un modo per rompere i disperanti dilemmi “o tutto o niente, o tutte o nessuna, o una per tutte” che spesso ha paralizzato la politica dei piccoli gruppi (e dei piccoli partiti della Sinistra) aprendo una litigiosità sterile. Anche il fare femminista-femminile può soffrire questo rischio, soprattutto quando nel gruppo convergono storie diverse, ma proprio noi, forti di una differente pratica politica, possiamo sperimentare nuove invenzioni per governare i conflitti e intendere il consenso».
Perché parlare di femminismi significa ancora parlare di minoranze di donne, perché molte e molti temono anche solo il termine? È un problema di mancanza di memoria storica della società?
«Il movimento femminista ha fatto un taglio – come alcune hanno detto – nella tradizione androcentrica patriarcale. Un taglio epocale, che avuto risposte molteplici e varie. Da parte delle donne che hanno iniziato un percorso di liberazione; da parte dei compagni di strada, che hanno manifestato a volte un silenzio stupito, imbarazzato, raramente complice, specie tra le fila della Nuova Sinistra, la cui crisi ha tuttavia comportato la perdita di un potenziale alleato sulla questione dei diritti; da parte della “donna qualunque”, con curiosità, indifferenza, invidia a volte; da parte dell’“uomo qualunque”, con atteggiamenti formati dai mezzi di comunicazione di massa: una informazione risicata sui fatti meno eclatanti, il silenzio sulle manifestazioni più visibili, l’irrisione quando l’immagine del movimento occupava la scena pubblica vistosamente. Perché stupirsi quindi della smemoratezza, dell’ignoranza, del disconoscimento che hanno accompagnato questa rivoluzione? Senza voler entrare nel merito di tutte le leggi di “tutela” (spesso in attuazione del dettato costituzionale) approvate a partire dagli anni Settanta, sollecitate direttamente o indirettamente dal Movimento femminista, leggi che hanno modificato la condizione materiale e le rappresentazioni culturali delle donne, dico che la rottura rivoluzionaria di quella “minoranza” è diventata senso comune. Se è vero infatti che i suoi nomi sono ignorati o fraintesi o negati, è pur vero che i suoi esiti hanno mutato la vita vissuta delle donne e degli uomini, più o meno consapevolmente».
Emma Baeri, Dividua. Femminismo e cittadinanza, Il Poligrafo, Padova 2013, 294 pagine, 22 euro
Intervista pubbicata su Letterate Magazine