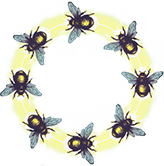Le donne e il lavoro
Il più grande nemico di una donna? La mancanza di tempo per se stessa. Non ha dubbi la giornalista e scrittrice Brigid Schulte, autrice di Overwhelmed: Work, Love and Play When No One Has the Time che in italiano potrebbe suonare più o meno così: Travolta: lavoro, amore e gioco quando non se ne ha il tempo. È una sensazione frustrante che va molto oltre il desiderio della stanza tutta per sé auspicata da Virginia Woolf, perché dentro e fuori qualunque “stanza” qualsiasi donna continua a essere sopraffatta e schiacciata da quell’insieme di lavoro produttivo, riproduttivo e di cura che, ancora oggi, nel 2019, traccia il discrimine netto fra lo status esistenziale e politico dell’essere maschio o femmina – quest’ultima, non necessariamente biologica e non necessariamente con prole, resta una femmina agli occhi della società e tali restano le aspettative su di lei.
Il nesso fra tempo per sé e il macrotema “donne e lavoro” è qualcosa che ancora non entra a pieno titolo nel dibattito pubblico del nostro Paese, soprattutto nel contesto attuale dove norme o misure economiche cercano di riportare le donne dentro le mura di casa, facendole essere mogli e madri in prima e ultima battuta, delegando a loro tutte quelle cure senza le quali probabilmente il sistema mondo andrebbe poco lontano.
Eppure, come andiamo dicendo da tempo con la collega Marina Turi, nel cromosoma X delle femmine
«non cʼè implicita una propensione maggiore a caricare la lavatrice, a utilizzare lʼaspirapolvere o il ferro da stiro, ad accudire mariti, amanti, figliolanza, persone anziane o disabili, animali domestici e piante in vaso, fino allo sfinimento o fino a che morte non ci separi. Esiste una cultura dominante che continua a ripetere e cerca di convincere che il mondo dellʼaffettività è femminile. Così le attività di cura includono necessariamente una componente affettiva, prevedono una dimensione emozionale e relazionale, e le donne si ritrovano obbligate ad accettare lavori e situazioni che le portano e le mantengono nella diseguaglianza».
Una diseguaglianza sistemica e reiterata che, ancora oggi, sempre nel 2019, vede l’Italia al 70esimo posto – su 144 Paesi – per equità di genere soprattutto in ambito economico e politico, come emerge dal report 2018 sul Global Gender Gap redatto dal World Economic Forum. Siamo al pari di Honduras e Montenegro e poco davanti a Tanzania e Capo Verde. In Europa Occidentale siamo al 17° posto su 20 Paesi: dopo di noi solo Grecia, Malta e Cipro.
Il dato più lesivo – ma forse è il caso di dire oltraggioso – è quello relativo alla disparità salariale: l’indice medio a livello mondiale per l’equità di salario a parità di lavoro fra maschi e femmine è del 64,5% e l’Italia è ferma al 51,2 % con una disoccupazione femminile al 12,5% e il tasso di inattività al 44% (Istat 2017). E sono 1 milione e 404 mila le donne fra i 15 e i 65 anni che hanno subito molestie e ricatti sessuali nell’arco della loro vita lavorativa.
Detto in altri termini: a fronte di una precarietà lavorativa, conseguenza di politiche neoliberiste che investono l’umanità tutta, a parità di mansioni, una donna non solo guadagna meno di un uomo, non solo deve continuare a lavorare quando rientra a casa, ma deve anche attrezzarsi ad affrontare forme più o meno subdole di violenza di vari livelli, senza che nessuna compagine politica comprenda fino in fondo che i costi sociali della violenza maschile sulle donne equivalgono a una finanziaria.
E anche in situazioni privilegiate, quando pezzi di lavori di cura vengono appaltati ad altre donne – con tutto quello che ne consegue, in termini di relazioni di potere, soprattutto fra donne native e migranti – resta il tarlo; l’aspettativa sociale cade come una mannaia su quel tempo liberato.
Sembra di assistere a un paradosso: da un lato, c’è ancora una fetta importante di donne che non accedono al mercato del lavoro, altre che subiscono le diseguaglianze salariali, altre ancora che per avere autorevolezza e potere decisionale nelle loro professioni si comportano o sono costrette a comportarsi come uomini (anche nominandosi al maschile); dall’altro, non viene ancora minimamente preso in seria considerazione il surplus di lavoro riproduttivo – non solo in termini di maternità – e di cura sociale che regolarmente le donne svolgono, senza essere sostenute da servizi anche minimi di welfare diffuso.
La quota tempo relativa ai congedi di paternità è una barzelletta e la minoranza di padri illuminati nel nostro Paese non fa massa critica in una cultura fortemente maschilista, specialmente nella testa di chi organizza spazi e tempi di lavoro.
Tortuga, think-tank di studenti, ricercatori e professionisti del mondo dellʼeconomia e delle scienze sociali, scrive su Il sole 24 ore:
«Allungare il congedo di paternità, stabilire una più alta retribuzione per il congedo parentale, e rendere più flessibile la distribuzione tra i genitori dei periodi di astensione dal lavoro possono essere importanti passi in avanti nel raggiungimento di una maggiore uguaglianza di genere. […] In questa direzione va la direttiva proposta nel 2017 dalla Commissione europea, che introduce un congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni e il diritto per entrambi i genitori di disporre di un congedo parentale individuale di due mesi, non trasferibili all’altro genitore e retribuito almeno quanto il congedo per malattia. In caso di approvazione finale della direttiva, tali misure dovranno essere adottate anche in Italia. In senso opposto va invece la legge di bilancio approvata nel dicembre 2018, che – con l’introduzione della maternità flessibile – prevede la possibilità per le lavoratrici di scegliere di lavorare fino al parto e di fruire di tutti e cinque i mesi del congedo in seguito alla nascita del bambino, previa autorizzazione del medico. Dunque, non solo non vi è alcun alleggerimento dell’onere sopportato dalla madre per quanto concerne la cura dei figli, ma con tale misura si danneggiano particolarmente le donne in difficoltà economica, che saranno molto probabilmente le uniche a usufruirne».
Oltre al dato, oggettivo, che nessun uomo si sentirà mai chiedere a un colloquio di lavoro «Lei per caso intende diventare padre?», mentre al contrario ancora oggi per le donne sia il desiderio di maternità che quello di non riprodursi può essere causa di discriminazione.
L’intreccio di tutti questi piani finora accennati è da sempre messo in rilievo dalle riflessioni femministe, soprattutto nelle più recenti elaborazioni, come il Piano nazionale contro la violenza [2017] di Non Una Di Meno [Nudm], dove il tema del “lavoro” connette, non a caso, differenti questioni e rivendicazioni, come quella di
«un welfare universale, gratuito e accessibile a tutt@: non basato dunque sul modello familistico vigente, piuttosto capace di riconoscere garanzie e diritti sociali non solo alle donne, ma alle persone migranti, alle soggettività lesbiche, gay, trans, queer e intersex; adeguato alle forme, alle relazioni, ai bisogni e agli stili di vita contemporanei e capace di liberare dalla coazione al lavoro sfruttato e sottopagato».
Le attiviste di Nudm chiedono
«servizi laici, gratuiti e non ingerenti rispetto alle scelte degli individui; così come riteniamo fondamentale anche il riconoscimento di esperienze autogestite e autonome di welfare – come per esempio i centri antiviolenza non istituzionali e le consultorie, esperienze fondate sulle pratiche femministe delle donne e in grado di sovvertire le forme di riproduzione sociale che impongono e fissano le identità e i ruoli di genere. In questo ambito riteniamo misure imprescindibili: il ri-finanziamento e il potenziamento dei servizi pubblici per l’infanzia, nonché l’accesso universale agli stessi (la priorità data ai genitori lavoratori determina infatti troppo spesso situazioni di disoccupazione forzata per le madri precarie); il rafforzamento dei servizi e delle infrastrutture a sostegno delle donne disabili, la cui carenza aggrava peraltro l’esposizione di queste ultime alla violenza; politiche reali per la cura dei familiari, delle persone anziane, degli individui, che affrontano la questione del lavoro riproduttivo e di cura e dell’organizzazione dello stesso come un problema che riguarda la società tutta e non soltanto, e “naturalmente”, le donne; più complessivamente, la costruzione di nuove infrastrutture sociali, capaci di liberare i nostri tempi di vita invece di costringerci una volta di più tra le mura domestiche».
Proposte chiare e concrete, mai assunte fino in fondo dai movimenti sociali misti o dai leader dei partiti di sinistra. Si è mai sentito qualcuno di loro porre ai primi punti del programma la redistribuzione del lavoro di cura come strumento per rimuovere le diseguaglianze, ad esempio, o il taglio dell’Iva sugli assorbenti, volendo entrare nel merito del paniere dei beni di prima necessità?
Resiste, anche a sinistra, non solo la persuasione che siano questioni secondarie perché derubricate a questioni di genere, ma anche l’idea, più in generale, che il lavoro produttivo – non importa se sottopagato, sfruttato, non qualificato – definisca sempre l’identità di ognuna/o di noi.
Ma non è questa l’identità né la vita che desideriamo, in tantx[1] pensiamo che il tempo liberato sia la premessa necessaria per il benessere non solo umano. Lavorare meno, meglio e lavorare tutte e tuttx non può ridursi a un semplice slogan elettorale: ora che la terra è al collasso, e le femministe – senza polemica – lo dicono da molto prima di Greta, è necessario redistribuire equamente non solo lavori e salari, ma anche restituire alle donne tutto il tempo mancato per loro stesse.
[1] Condivido da tempo la necessità di usare un lessico sessuato al posto di quello sessista – ed è sessista anche l’uso neutro e onnicomprensivo del maschile. Rispetto al plurale dei generi e dei sessi da riprodurre quando comunichiamo, fra le varie diverse possibilità sperimentate, ho accolto l’uso della x, già adottato da alcuni governi che danno la possibilità di mettere la x per eliminare il binarismo maschio/femmina da documenti di identità e burocratici.
Articolo pubblicato sulla rivista Luoghi Comuni, n°3/4 2019