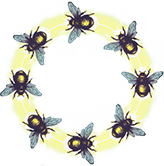Le straniere di Algeri – intervista a Assia Djebar
Una terra dilaniata che fatica a riconquistare la pace. Così appare l’Algeria, non solo per la guerra civile che l’ha attraversata a lungo ma, anche, per le contraddizioni interne a una società di per sé complessa. Alla vigilia delle prossime elezioni, previste per l’8 aprile, il paese vive ancora sotto lo stato di emergenza proclamato nel 1992 per combattere il terrorismo islamico, e più di cento persone sono morte dall’inizio dell’anno, vittime di violenze non del tutto sedate. A raccontare quello che non sappiamo dell’Algeria, dall’indipendenza in poi, c’è Assia Djebar, scrittrice, e da alcuni anni insegnante di letteratura francofona alla New York University. L’abbiamo incontrata durante il suo soggiorno in Italia, ai primi di marzo, dove è stata protagonista dell’iniziativa «Dedica 2004», promossa dall’Associazione provinciale per la prosa di Pordenone.
A Pordenone è stato presentato il suo ultimo libro, «Queste voci che mi assediano», edito da Il Saggiatore, che, a differenza degli altri, non è un romanzo. Perché ha sentito la necessità di una raccolta di saggi e di riflessioni sul linguaggio?
Perché sono almeno dieci anni che i miei romanzi vengono studiati nei programmi d’esame statunitensi e da tempo mi si chiedeva di intervenire a dibattiti e incontri. Addirittura il dipartimento di francese, che non ha mai avuto molti iscritti, ha messo l’insegnamento della letteratura francofona maghrebina, africana sudsahariana e delle isole caraibiche, proprio per non perdere altri studenti… Da da tempo vivo a Parigi, ho fondato il parlamento degli scrittori insieme a Salman Rushdie, e dopo la violenza in Algeria non sono tornata spesso nel mio paese. A un certo punto, quindi, mi sono chiesta: cos’è la francofonia? Era al di fuori della mia persona… pensavo. Ma nel ‘95, alla morte di mio padre, ho capito che non potevo più stare in Algeria e ho deciso di dirigere un centro di francofonia prima in Louisiana e poi a New York, insieme ad altri autori francofoni. I testi che ho raccolto in questo volume sono stati scritti proprio per i primi anni di insegnamento, che mi ha imposto un’auto-analisi sulla mia lingua. Non ho mai ripetuto lo stesso intervento, ho sempre rivisto la mia scrittura.
Il sottotitolo del libro dice «Scrivere nella lingua dell’altro»: cosa significa?
Come scrittrice algerina, posso dire che ci sono due livelli. Il primo è che avevo due lingue: quella della scuola e dell’Algeria coloniale e quella di mia madre, quella del fuori e quella del dentro. Del resto, è la situazione di tutti i migranti: che siano i turchi in Germania o i tunisini in Italia. Il bambino a scuola impara la lingua dell’altro, mentre la sua serve solo per ricordare il passato e le radici.
Il secondo livello è dato dal fatto che io vengo da un paese musulmano, con una cultura, che lo si voglia o no, che ha accentuato la segregazione sessuale sotto il peso della tradizione. Io non credo che ciò sia collegato all’Islam e al suo spirito, e per questo ho scritto «Lontano da Medina». Al contrario, penso che questa separazione sia stata una sorta di difesa – che si è protratta nei secoli – al colonialismo e all’imperialismo. In Algeria è stato più forte che altrove, ma lo ritengo comunque un modo per preservare e conservare le proprie origini.
Le donne in Algeria hanno sempre occupato posizioni di retrovia, e del resto nell’Islam le donne non possono sposarsi al di fuori della loro religione. Se ad Algeri non ci fosse stato questo freno, visto che l’Algeria era considerata dai francesi una colonia da popolare, avremmo avuto, come in America latina, donne indigene messe incinte dagli occupanti e poi abbandonate. In Algeria non è stato così, e tuttavia ci sono un milione di francesi algerini. È da queste retrovie che si possono conservare riti e tradizioni, per questo è come se tutta l’identità profonda fosse femminile.
È ancora convinta, come affermava negli anni novanta, che saranno le donne a salvare l’Algeria?
Lo penso sempre. Io ho iniziato l’università nei primi giorni dell’indipendenza e allora ho cominciato a scrivere. Dal ’62 all’82 c’è stato un forte processo di liberazione ed emancipazione, le donne algerine hanno avuto accesso alle scuole e alle professioni.
Il problema di oggi è [poiché in Algeria c’è il petrolio, non dimentichiamolo] che è avvenuto anche un forte arricchimento del paese, ma non una redistribuzione a tutta la popolazione. E non è cambiato il rapporto con la religione, che anzi è arrivata al livello politico. Ma se negli anni novanta, al tempo della violenza islamista, quando Algeri doveva diventare Teheran, l’Algeria è rimasta una repubblica laica, nonostante i 200 mila morti da entrambe le parti, è perché le donne hanno fatto resistenza, soprattutto nella classe media. Negli ultimi tempi seguo maggiormente le vicende del mio paese attraverso Internet, ma so che le associazioni che lavorano dal basso, per conservare la democrazia, sono quasi tutte di donne. E non si occupano solo dei diritti per le donne e i bambini.
A Parigi, un paio di settimane fa, nel quartiere in cui vivo, che è popolato da africani, cabili e asiatici, ho letto un giornale algerino e mi ha colpito una frase di uno dell’opposizione, che diceva: l’Algeria è un paese ricco per un popolo povero. Senza contare che il governo vieta di comperare i libri dall’estero. Sono rimasta senza parole, ho ripensato a dieci anni fa, quando gli islamisti hanno ucciso tanti uomini di cultura, molti miei amici..
A proposito di questo, a breve ci saranno le elezioni in Algeria. Quali sono, secondo lei, le maggiori difficoltà che deve affrontare la società civile, in un momento in cui sembra attenuarsi l’emergenza dei fondamentalismi?
Non vorrei rispondere a domande sulle elezioni, perché credo possa farlo solo chi vive lì più di sei mesi. Io non ci torno, e non perché non voglia… del resto, anche il mio lavoro richiede tempo. Sono due anni che lavoro a un libro su Sant’Agostino, nato nella mia città. Ho deciso, in questo momento, di stare nel mio paese del quinto secolo dopo Cristo. Perché, in un certo senso, è un libro su mio padre, mio nonno, sul rapporto con i padri, al plurale, e più semplicemente perché Agostino nel quinto secolo lottò contro i donatisti, cioè gli integralisti cristiani che esistevano allora ed erano molto potenti.
È interessante capire come la ricerca del cosidetto purismo o della purezza porti fatalmente alla violenza. A dimostrazione che non è la religione in quanto tale a crearla. Quindi mi sto occupando anche dell’identità, ma a monte del presente. Invece, su quello che accade in questi giorni, ho pensato di fare un corso sulla comparazione tra la letteratura algerina francofona e quella di Haiti, la prima repubblica nera. Per far vedere le similitudini culturali che stanno portando Haiti alle stesse nostre conseguenze politiche…non è un caso che in Algeria l’integralismo c’è stato prima che in tutti gli altri stati. Quando chiamo il mio vecchio zio e mia madre sono tranquilla, il fatto che accadano ancora delle violenze non significa che in tutto il paese non ci sia resistenza. Ci sono universi che continuano a vivere, le donne continuano a emanciparsi con un ritmo «reale», direi. Anche senza rivoluzioni. E i miei romanzi sono ancorati tutti alla mia terra, nonostante non abito più lì. Chissà, dopo Agostino, magari mi occuperò di mistici musulmani e forse avrò diritto di vivere a Damasco, alla fine della mia vita… Più si invecchia e più ci si rende conto che la propria patria è più grande di quanto si creda.
In uno dei suoi saggi, lei dice che ama la vita e ritiene la lingua anche un mezzo di trasformazione, una pratica come un’avventura. Anche per cambiare il mondo?
Alla fine, si tratta del rapporto con il corpo, perché scrivere è anche questo, e ciò determina il cambiamento. Un esempio, le ragazze più giovani di me, negli ultimi anni che ero in Algeria, conoscevano mezza Africa perché stavano nella squadra di basket. Abbiamo avuto una campionessa di corsa, era stupefacente vederla arrivare al traguardo. Lo sport femminile è stato una rivoluzione e continua ad esserlo.
L’Algeria è sicuramente indietro, rispetto a Marocco o Tunisia, quando si tratta di dare ruoli di responsabilità per il governo a delle donne, ma questo non ferma il resto.
Il corpo è anche una lingua, anzi fa parte di quel che lei chiama «beccheggiare di lingue»…
Sì, almeno per quel che riguarda noi donne algerine, ce ne sono quattro, di lingue: quella dell’Islam, quella berbera o della roccia, quella francese [ma c’è stato anche il latino o il turco], e poi quella del corpo, che appartiene alle donne. È quella dell’amore e della fantasia. Mia nonna ballava e c’è sempre la danza nelle feste, un aspetto africano per eccellenza. A Parigi, c’è la comunità del Mali, dove le donne esprimono nel ballare una gioia frenetica e una sensualità estrema, tutt’e due fortemente legate alla loro interiorità silenziosa.
(pubblicato su Carta n°12/2004, www.carta.org)